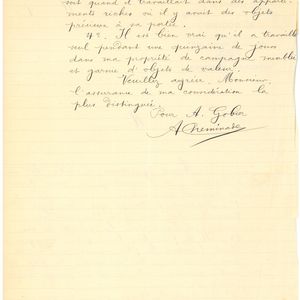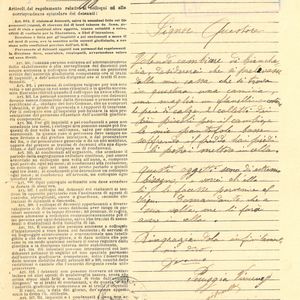Vincenzo Peruggia era nato a Dumenza, in provincia di Varese, l’8 ottobre 1881, da Celeste Rossi e Giacomo Peruggia.
Le sue generalità e gli episodi più rilevanti ai fini delle indagini si ricavano dai diversi interrogatori a cui viene sottoposto, ma le notizie più interessanti sulla sua vita sono riportate nella perizia psichiatrica effettuata dal dott. Amaldi, Direttore del Manicomio di San Salvi di Firenze, su richiesta degli avvocati difensori. Il medico, durante numerosi incontri in carcere, ha modo di approfondire la sua biografia e traccia un approfondito profilo psicologico dell’imputato. Contatta il medico condotto di Dumenza, che gli riferisce l’inesistenza di precedenti in famiglia, tranne uno zio paterno alcolista e omicida, condannato al carcere a vita, e la sostanziale buona reputazione morale di cui godevano sia Peruggia sia la sua famiglia.
Prima del furto
Vincenzo iniziò a lavorare a 12 anni come imbianchino a Milano; successivamente si recò a Lione, seguendo il padre muratore, che era solito emigrare periodicamente verso la Francia. Nel 1900 ebbe un primo episodio di “intossicazione saturnina”, causata dalle vernici a base di piombo usate nel suo lavoro di imbianchino e decoratore. Venne riformato per gracilità alla leva e nel 1902 si recò per la prima volta a Parigi. Negli anni successivi si spostò di nuovo a Milano, poi a Sondrio, finché nel 1908 tornò a Parigi, per stabilirvisi definitivamente. Risale all’epoca del viaggio verso Parigi un episodio che si rivelerà poi centrale nella sua vita, riportandone, secondo le parole del medico, una “incancellabile mortificazione”: durante una sosta a Mâcon decise di prestare 15 franchi ad un compagno di viaggio, un operaio francese che non aveva i soldi per il biglietto fino a Parigi; dopo aver pranzato insieme e aver bevuto troppo, trovarono per strada dei ragazzi che facevano rotolare un grosso tubo di terracotta, li rimproverò e mentre tentava di spostare il tubo al lato della strada lo ruppe; qualcuno chiamò la polizia, che lo arrestò; dopo due giorni di arresto fu processato e condannato per furto a 24 ore di carcere. Secondo le sue stesse parole, questo episodio non fu altro che “una cattiveria e un atto di sciovinismo tiratomi addosso perché ero italiano”.
Giunto a Parigi iniziò a lavorare per la ditta A. Gobier, dove rimase per tre anni lavorando come decoratore in case private, alberghi, uffici pubblici, e, tra il 1909 e il 1911, al Museo del Louvre. Peruggia racconta di essere stato trattato con freddezza e avversione dai colleghi e di essersi invece guadagnato la fiducia del padrone. Il medico scrive dunque a Gobier, il quale conferma, in una lettera allegata alla perizia, di non aver mai dubitato dell’onestà di Peruggia, di averlo incaricato, in qualità di operaio anziano, di fare la paga agli altri operai, e di avergli affidato anche i lavori nella sua casa di campagna, dove erano mobili e oggetti di valore.
In quegli anni a Parigi gli capitò un altro spiacevole episodio giudiziario, quando fu condannato a 8 giorni di carcere e 16 franchi per violenze e porto d’arma vietata: una sera, dopo una bevuta di troppo con gli amici, incontrò una prostituta che tentò di adescarlo, rifiutandola lei lo accusò di violenze. Quando venne arrestato gli fu trovato in tasca il coltello a serramanico che portava per lavorare e tagliare il pane.
L'idea del furto
Come riferirà sia agli inquirenti sia al medico, fu nei giorni in cui lavorava al Louvre che maturò l’idea del furto. Aveva sentito dire che molti dei quadri esposti erano di pittori italiani e aveva visto in un libro una rappresentazione dell’arrivo al museo delle opere sottratte da Napoleone all’Italia. Pensò dunque che avrebbe voluto riportare almeno un quadro in Italia: inizialmente aveva pensato alla “Bella giardiniera” (la “Madonna con il bambino e San Giovannino” dipinta da Raffaello e acquistata da Francesco I), ma era troppo grande. Confessò infatti di aver scelto la Gioconda la mattina stessa, guardandosi attorno nel Salon Carrè, per semplici motivi di praticità: il dipinto era di minori dimensioni rispetto agli altri, perciò più semplice da sottrarre e nascondere.
Interrogato dal medico in merito ai suoi sentimenti in quei momenti, Peruggia dichiarò: “mi sono sentito sempre calmo, molto contento di riuscire in quello che volevo”, tuttavia “capivo che avevo rubato, sapevo che se in Francia mi avessero preso, mi avrebbero mandato a Cajenna [colonia penale nella Guyana francese] per otto o dieci anni almeno”, “ladro sì mi sono sentito, ma dopo tutto avevo rubato roba nostra […] e ladri erano stati anche loro, i Francesi”, e infine “io ero sicuro di potermi aspettare un bel compenso dall’Italia. Pensavo che restituendo la Gioconda all’Italia i dirigenti italiani sarebbero stati ben contenti, e che se la Francia avesse reclamato essi l’avrebbero persuasa a tacere adattandosi a cedere almeno la Gioconda in cambio della gran quantità di quadri Italiani rubati dalla Francia, o che perlomeno essa avrebbe chiuso un occhio…”. Da qui si deduce il gigantesco equivoco in cui Peruggia era caduto: sicuro di aver compiuto un gesto eroico per il suo paese, si era convinto di non essere penalmente perseguibile una volta oltrepassata la frontiera.
Il profilo psicologico
L’analisi delle lettere inviate alla famiglia in quegli anni parigini e sequestrate dagli inquirenti, condusse i giudici a consolidare le loro ipotesi riguardo alla finalità di lucro. Lo psichiatra invece, dalla forma enfatica e puerilmente ricercata con cui esprimeva la speranza in una imminente fortuna, associata alla sincera convinzione di meritare un premio per il suo gesto, trasse conferme per elaborare la sua diagnosi. Nell’esame dello stato psichico il medico sostenne che la calma imperturbabile e la freddezza inespressiva dell’imputato non erano da interpretare come anaffettività o amoralità o cinismo, ma come una debolezza dei mezzi espressivi: “egli è piuttosto un muto che un sordo delle voci del sentimento”. A questo aspetto aggiunse inoltre che i suoi difetti psichici si manifestavano “in una povertà di elaborazione logica, in una scarsa capacità riflessiva, in una pochezza decisamente patologica di critica, di conseguenza in una eventuale assurdità della condotta”. Da queste considerazioni il perito ricavò una diagnosi di “frenastenia a forma di semplicità di spirito, forma costituzionale quindi sussistente anche nel momento del delitto”, una inferiorità mentale tale da ridurre il grado della sua imputabilità, ma non tale da renderlo pericoloso a sé e agli altri.